Mi è capitato talvolta che all’apertura di Open Office (versione 2.2) venisse avviata la procedura di recupero file corrotti (di solito in seguito ad un crash del programma o ad un arresto inatteso del sistema). Ogni tanto capita che, se fallisce il ripristino di uno o più files, al suo avvio Open Office mostri la schermata di ripristino perché i file da ripristinare non sono più disponibili nella cartella /tmp/, e il ripristino non è comunque più possibile. Questa situazione è destinata a permanere in eterno perché il recupero non può più essere effettuato.
Un modo per rimediare è il seguente:
Posizione file dei recuperi OpenOffice:
<home>/.openoffice.org/user/registry/data/org/openoffice/Office/Recovery.xcu
La guida online (F1) recita:
Avviare il Programma di notifica errori. Nella maggior parte dei casi di crash del software, il Programma di notifica errori si avvia automaticamente. Tuttavia, se il software sembra essere bloccato e il programma non si avvia automaticamente potete avviarlo manualmente:
Accedete alla cartella del programma {office_install_path}/ e avviate il file crashrep.
Workaround alternativo:
Esco da OO (se già aperto). Con OO spento:
$ vi <home>/.openoffice.org2/user/registry/data/org/openoffice/Office/Recovery.xcu
cancello le righe relative ai documenti citati nel prompt iniziale (nel campo oor:name) e le sostituisco con le righe:
<node oor:name="recovery_item_2" oor:op="remove"/>
dove anziché item_2 può essere un item diverso, di solito più righe uguali in ordine da 1 a 15). Salvo e riavvio OO. Non appare più il prompt di recovery.
Nella versione 3.2 che ho in questo momento, tuttavia, il problema è stato risolto, per cui non serve alcun intervento (la coda dei file da ripristinare si svuota da sola).

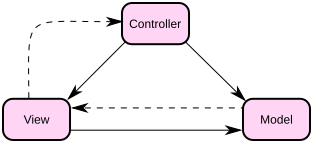

Commenti recenti